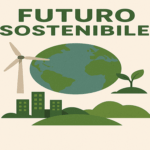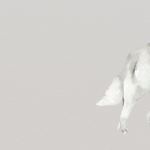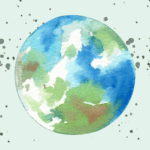Il 4 aprile scorso quello che doveva essere il disegno di legge “Sicurezza” è stato approvato dal governo, nella forma però di decreto-legge, per evitare la discussione in aula di un testo che aveva raccolto molte critiche e dubbi di costituzionalità, espressi anche da istituzioni nazionali e internazionali. Lo stesso presidente Mattarella ha fatto presente sei rilievi, che sono stati accolti nella versione definitiva del decreto. Nel momento in cui scriviamo il testo del nuovo decreto-legge non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma il suo contenuto è stato riassunto in un comunicato stampa dal governo.
Tra i requisiti costituzionali di straordinaria urgenza e necessità che giustificherebbero il ricorso al decreto-legge è compresa la detenzione in carcere di una donna incinta o madre di un bambino fino a 1 anno di età. Se ne era già parlato su Scienza in rete e ora torniamo sul tema. In base al codice penale, se il bambino o la bambina ha meno di un anno di età, l’esecuzione della pena della madre deve essere rimandata. Ed è proprio questa obbligatorietà che il disegno di legge “Sicurezza” voleva eliminare, rendendo il rinvio solo facoltativo e quindi sottoposto a una valutazione caso per caso. Inoltre il disegno di legge chiedeva che il rinvio non fosse concesso se dalla madre potesse derivare il rischio di «una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti».
L’intervento del presidente Mattarella ha ripristinato l’obbligatorietà nel testo del decreto-legge, che precisa che l’eventuale custodia cautelare per le donne indagate o imputate con figli al seguito sia eseguita obbligatoriamente in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) se i bambini e le bambine hanno un’età inferiore a un anno, mentre per le madri di bambini e bambine di età tra gli uno e i tre anni la pena potrà essere eseguita, in alcuni casi, anche in carcere. Inoltre, il decreto introduce una serie di disposizioni relative alla custodia cautelare e una relazione che il governo dovrà presentare in Parlamento entro il 31 ottobre di ogni anno.
Insomma, una legge presentata come un insieme di «norme necessarie che non possiamo più rinviare per rispettare gli impegni presi con i cittadini e con chi ogni giorno è chiamato a difendere la nostra sicurezza», come ha dichiarato la presidente del Consiglio, inserisce tra le misure di sicurezza indispensabili privare i bambini della libertà.
Bambini e bambine negli Icam, che cosa sappiamo?
Sono quindici attualmente le donne detenute con i rispettivi figli e sono quattro gli Icam in Italia, dopo la chiusura nel febbraio scorso di quello di Lauro, in provincia di Avellino, l’unico situato al Sud (i cui ospiti sono stati smistati nelle altre strutture).
Grazie all’impegno del Garante per le persone private della libertà della Campania, siamo in grado di disegnare un quadro delle condizioni di vita e di salute di questi bambini e bambine. A gennaio, a Lauro erano cinque le coppie mamma-bambino detenute, nessuna per reato di borseggio (le borseggiatrici sono tra i bersagli della severità del decreto). Uno dei piccoli era all’Icam sin dalla nascita, mentre gli altri quattro avevano dai 6 mesi ai 2 anni d’età al loro ingresso e dovevano rimanerci ancora da 2 mesi a 3 anni, a seconda delle condanne ancora da scontare delle loro mamme. Nessuno di questi bimbi e bimbe soffriva di una malattia cronica o una disabilità; uno era nato sottopeso (2100 g da parto cesareo) e un altro non era ancora in regola con il calendario delle vaccinazioni obbligatorie. Due bambini erano stati ricoverati in ospedale prima del compimento di un anno per malattie acute polmonari. Nessuno dei bambini all’Icam di Lauro ha ricevuto le visite di un pediatra per i previsti bilanci di salute, ma solo al bisogno. Per tutti, lo sviluppo del linguaggio, del movimento, della sfera cognitivo-relazionale e alimentare rientrava nelle tappe temporali previste, almeno secondo il giudizio delle mamme, non del pediatra. Un bambino frequentava la scuola d’infanzia e due la scuola primaria, seguiti anche per il doposcuola; gli altri 2 svolgevano attività con gli educatori una volta la settimana. Un bambino non aveva mai ricevuto visite, né colloqui (neanche video) con i familiari, gli altri settimanalmente.
Dei bambini e bambine rinchiusi negli altri Icam non è facile riuscire ad avere a sistema informazioni dettagliate.
Non è un carcere?
Non è il carcere, è l’Icam, ma in queste condizioni, comunque, alcuni dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, vengono indiscutibilmente negati. Tra questi il diritto alla salute, che la nostra Costituzione riconosce nell’articolo 32, che ne ribadisce l’importanza fondamentale per tutti i cittadini, compresi quindi i più piccoli.
Le avversità precoci subite nell’infanzia, e in particolare nei primi due anni d’età, possono plasmare la struttura stessa del cervello, indebolendo la rete di fibre che collega le diverse regioni cerebrali e portando a una riduzione delle capacità cognitive in età adulta.
L’ambiente carcerario (che siano sezioni nido delle carceri o Icam) è assolutamente inconciliabile con la crescita e lo sviluppo sano e naturale di un bambino o una bambina, costretti a vivere i primi anni della vita in un contesto di deprivazione affettiva, relazionale e sensoriale. Cosa che porta al manifestarsi di difficoltà nel gestire le emozioni e a un senso di inadeguatezza, di sfiducia, di inferiorità, che si accompa a un tardivo progresso linguistico e motorio, causato dalla ripetitività dei gesti, dalla ristrettezza degli spazi di gioco, dalla mancanza di stimoli.
Gli arresti domiciliari per donne incinte o con bambini fino a un anno erano una norma antica e consolidata nella nostra giurisdizione, addirittura prevista dal codice Rocco; abolirla e stabilire che adesso andranno non in carcere ma in un Icam, che è pur sempre un carcere, dove è negato il principio di territorialità della pena, il diritto all’affettività, alla famiglia e all’inclusione sociale innanzitutto è compiere un’ingiustizia.
Bambine e bambini detenuti insieme alle mamme sono vittime di reati che subiscono ma cui, tuttavia, devono contribuire a espiare la pena.
Davvero bambini e bambine sono un pericolo per la nostra sicurezza?
Probabilmente l’intervento del presidente della Repubblica aveva lo scopo di evitare uno scontro istituzionale, proponendo una via di mediazione. Tuttavia sembra palese che le conseguenze a distanza sullo sviluppo del bambino non siano state valutate dai decisori, e tantomeno saranno considerate al momento della definizione della pena per le donne madri. Non ci sono o non potrebbero esserci misure alternative alla detenzione di vittime innocenti quali sono i bambini in carcere con le mamme? È fuori dubbio che gli interventi dovrebbero essere posti in essere prima, che dovrebbero essere preventivi ed efficaci; non solo giudiziari ma anche politici e sociali. Ma questa è la sfida e la responsabilità di tutti per la garanzia dei diritti: tutti i diritti umani e per tutta l’umanità.
La detenzione di bambini innocenti è disumana anche perché non riconosce il supremo interesse del bambino nell’orientare azioni e decisioni.